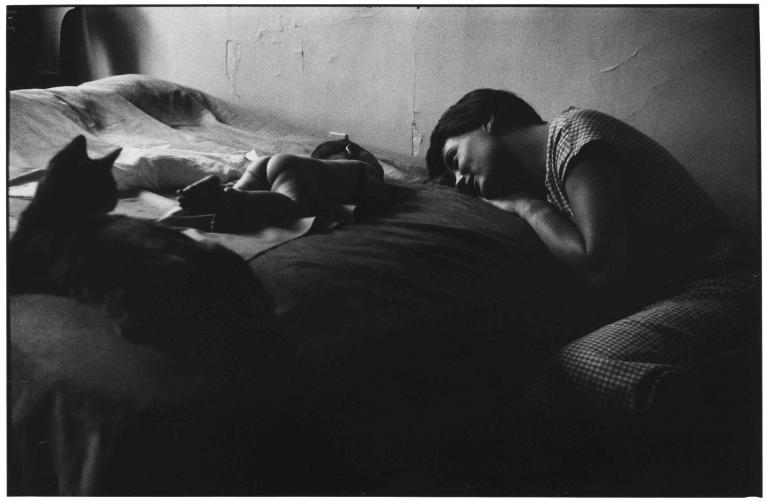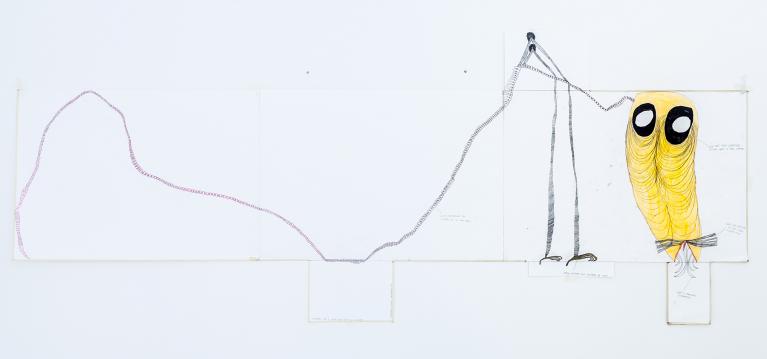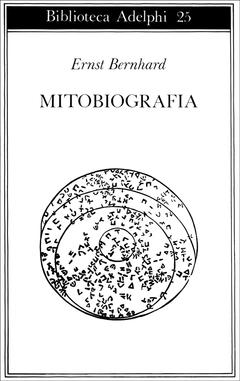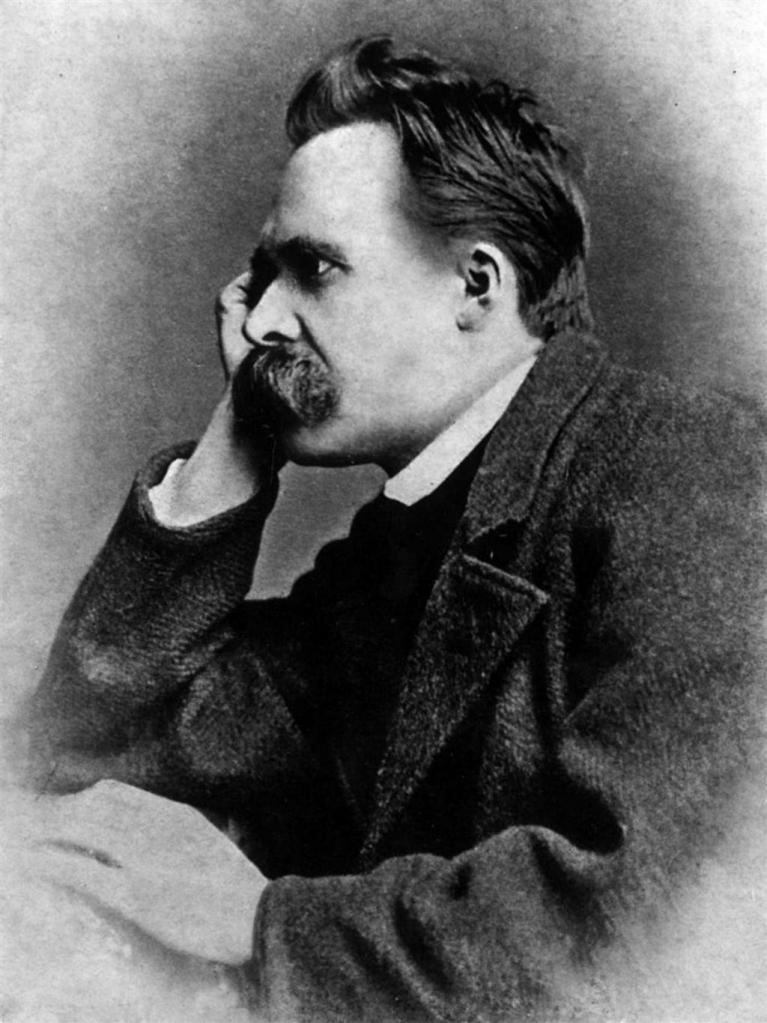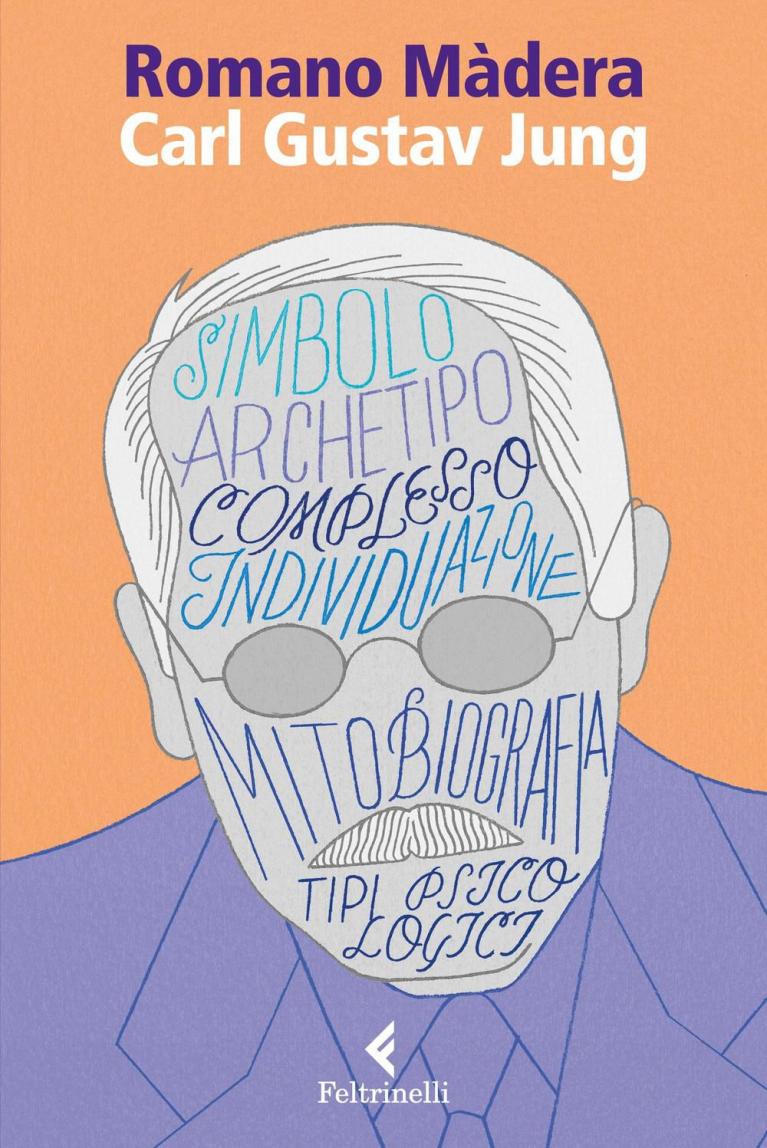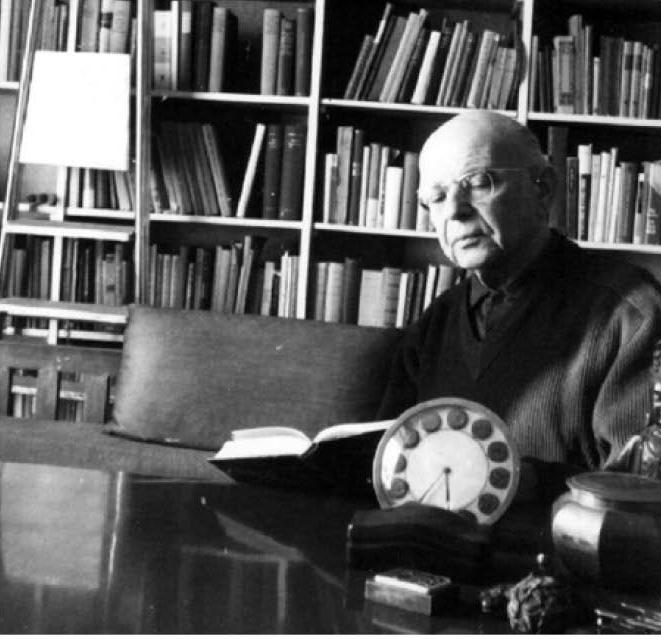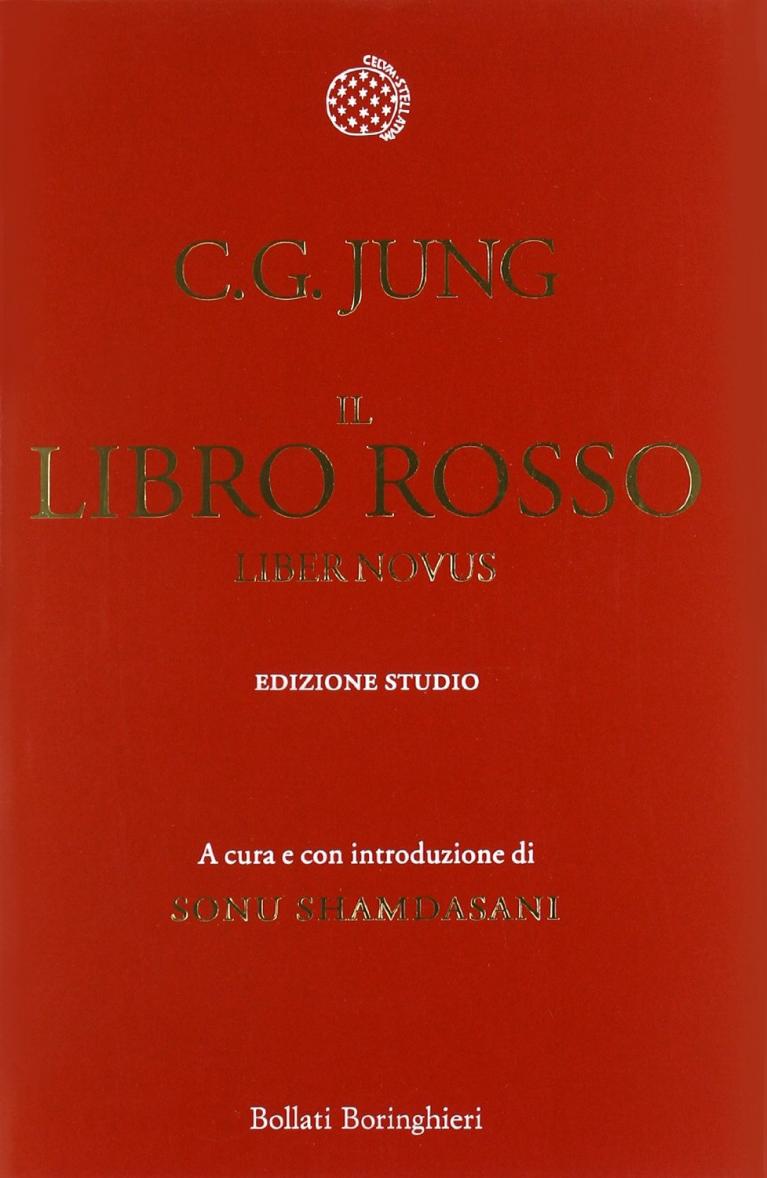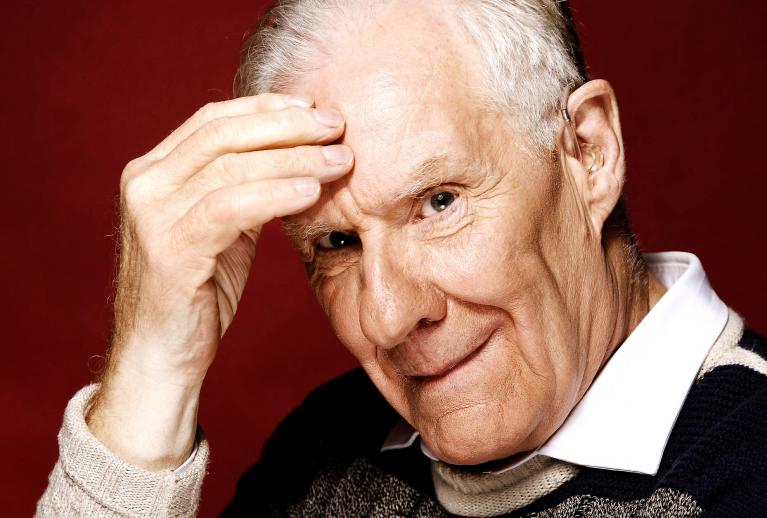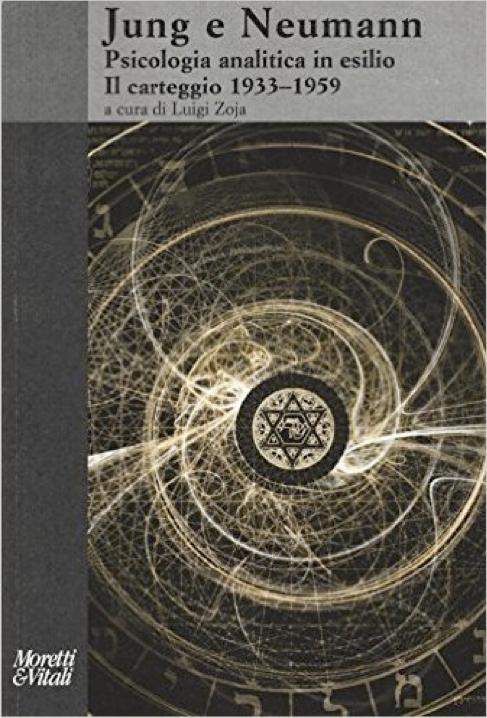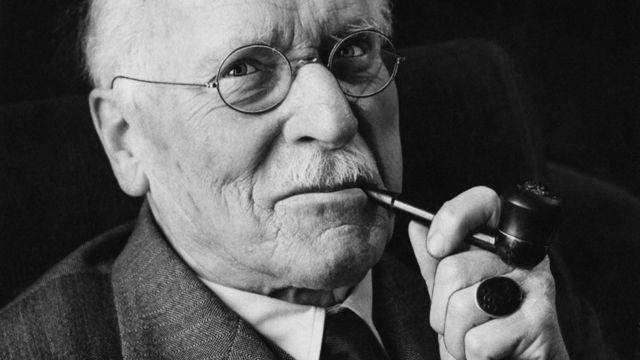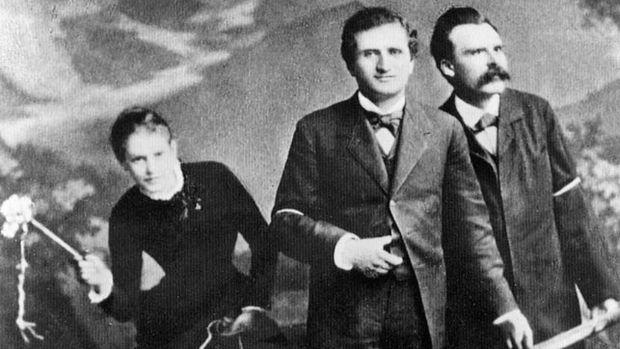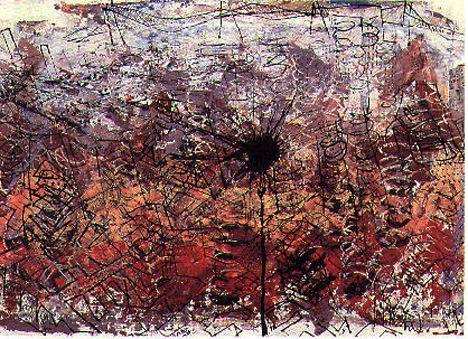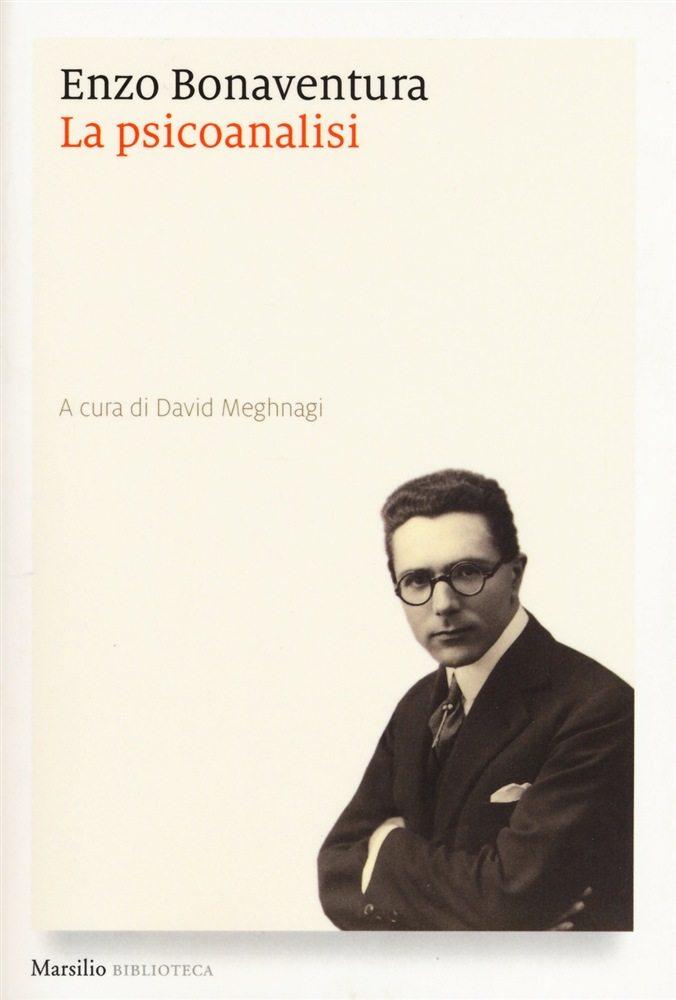Vorrei mettere in luce un aspetto trascurato che riguarda la violenza sulle donne, proprio in questi giorni che possiamo avere un ascolto più attento grazie alla istituzione della Giornata mondiale contro la violenza sulla donna.
Nei dibattiti che ascoltiamo, nei discorsi degli esperti, nei libri che leggiamo troviamo molte riflessioni sul fenomeno, ma abbiamo anche la sensazione che non si tocchi il punto, sembra che non abbiamo ancora trovato un grimaldello abbastanza potente da modificare non dico il corso delle cose, ma almeno la posizione soggettiva della vittima. Fornire alle donne decaloghi di comportamento degli uomini violenti ha una sua utilità, ma occorre tener conto che una donna che si è legata a un uomo ammaliatore può non riconoscere, in lui, queste condotte pericolose. Una donna deve senz’altro sapere che il partner violento è quello che definisce unilateralmente le regole della relazione, che è geloso oltremisura ed esercita uno stretto controllo, che la ricatta e la svaluta psicologicamente, che vuole farla sentire sempre in colpa per poterla dominare e che tenta di isolarla dal mondo: si tratta di elenchi che non toccano, però, il punto nodale. Sono decaloghi che si continuano a ripetere come un mantra, ma che non sembrano promuovere un risveglio nelle vittime.

© Marina Ballo Charmet
È di questo che voglio parlare, del risveglio delle vittime, del perché non avviene. del perché le misure sociali sembrano inefficaci. Ciò non è dovuto esclusivamente al fatto che le denunce che le donne fanno coraggiosamente restino lettera morta: certo, questo è un aspetto che va subito attentamente monitorato e corretto. Eppure, anche allora, resterebbe qualcosa che ci sfugge. Dopo tanti anni di presenza sul territorio dei centri antiviolenza, di organizzazioni dedicate, di donne valorose che dedicano la loro vita al salvataggio di altre donne, perché continuiamo ad ascoltare nella voce delle operatrici di questi servizi una nota di disagio profondo, di frustrazione nel vedere come la loro battaglia quotidiana non riesca ad essere risolutiva. Cosa c’è che fa ostacolo?
La causa non è neppure identificabile, semplicemente nel dire che il maschio è violento: sostituire la lotta di classe con la guerra tra i sessi non fa bene a nessuno e soprattutto non giova all’importante idea di una differenza, quella che ci permette di pensare (si pensa a partire dal due, da almeno due cose o posizioni in contrasto). Non è scavando un solco - pensando di dividere il bene dal male - che ne usciamo.
Quello su cui vorrei concentrarmi è la difficoltà delle vittime a uscire dal loro stato. È questo che mi interessa, anche in quanto donna: cosa c’è che ostacola all’interno della vittima il suo processo soggettivo di devittimizzazione? Quale legame tiene legata una donna al carnefice che la manipola, la controlla, la denigra e la batte? Dove nasce, che struttura ha, di che pasta è questo nodo? Quale è la sua origine? Perché le donne implicate in questa ragnatela affettiva vi restano così tanto tempo, spesso anni? Perché resistono così a lungo alle umiliazioni, alle molestie, alla violenza?
Sappiamo che uno dei meccanismi di difesa del soggetto sottomesso è minimizzare il torto subìto: c’è una difficoltà della vittima nel riconoscersi oggetto di abuso e si arriva fino al diniego dell’evento traumatico o alla sua amnesia, o alla minimizzazione, oppure al cosiddetto go and stop, cioè prendere la decisione di andarsene, magari facendo i preparativi, per poi, alla fine, restare, come fosse ogni volta la prova generale di una prima dal debutto assai incerto.
La loro resistenza all’abuso, come dicono molte studiose e studiosi del tema, è probabilmente dovuta alla loro grande “generosità”, al fatto che si tratta di donne, spesso piene di vita, che si assumono l’incarico disperato di pensare di poter cambiare un partner ritenuto fragile e da proteggere: qui si tocca il paradosso della donna abusata che pensa a proteggere il suo uomo violento, come fosse un bambino sfortunato. Queste donne non demordono, non rinunciano perché non possono arrendersi al fatto che non ci sia nulla da fare e cercano fino all’ultimo di comprendere e cambiare il loro compagno svalutante e aggressivo. Non lo possono abbandonare al suo destino perché se ne sentono responsabili, e così il paradosso continua. Qui si colloca una certa onnipotenza della vittima che crede di poter sopportare all’infinito, fino alla morte.
Allora quale è il motore pulsionale, il perturbamento affettivo originario da cui prende forza questo delirio paradossale della vittima che non riesce a chiudere il legame e, in molti casi, protegge il suo usurpatore?
Ci avviciniamo al punto, forse, proprio cominciando a chiederci qual è il senso di questo strano fenomeno della “comprensione” della donna per il suo aguzzino: essa poggia sulla regolarità per cui l’offensore, dopo l’abuso, circonda la vittima di nuove cure e attenzioni. La donna vive, così, in un doppio regime di abuso e premura. E da qui vorrei partire con la mia proposta teorica.
Il doppio regime è un punto importante non tanto o non solo perché ci dice qualcosa sullo spaesamento della vittima presa in due opposte ingiunzioni, ma è fondamentale perché rimanda quasi sempre a un’altra scena, più originaria, in cui la costrizione e la premura, il controllo e la simbiosi convivevano. Si tratta di scene che rimandano all’infanzia e all’adolescenza, scene che non raccontano tanto di un bambino “classicamente”, per così dire, maltrattato dal proprio genitore, ma piuttosto il contrario perché spesso non si tratta di un abuso evidente ma di una sorta di “predilezione”, pur se di una predilezione a matrice perversa. Mi riferisco, più precisamente, al tipo di relazione che instaura quel genitore Pigmalione, di cui parlo nel mio libro dal titolo Mio figlio mi adora. La prima ipotesi che qui voglio avanzare è, precisamente, che il figlio o la figlia in ostaggio di un genitore Pigmalione e la donna vittima di violenza sono entrambi irretiti dalla doppia rete premura-costrizione. Ciò fa sì che siano anche posseduti dall’idea inconscia che il loro carnefice sia quell’Unico in grado di offrire loro riparo, protezione, amore. La donna vittima crede alla legge perversa di un coniuge maltrattante: è sotto il segno della crudeltà che può arrivare a credere di essere amata. Anna, una donna che aveva avuto sempre uomini controllanti come la madre, a proposito dell’ultimo, che era anche manesco, diceva: “Se picchia me, picchierà anche chi fa del male a me; lui in fondo mi ama e mi difenderà”. La donna era entrata in un dispositivo di marca mafiosa, nel quale lui le offriva “protezione” in cambio di assoggettamento. La questione cruciale, sovente elusa, è il fatto che le vittime di vincoli tossici offrono ai loro carnefici un consenso inconscio che rende poco incisivi gli interventi giuridici e sociali in loro favore.
Chi è il genitore Pigmalione? Il genitore Pigmalione è molto diffuso, un tempo tra i padri e, oggi, piuttosto tra le nuove mamme (in questo caso ho parlato di tratto plusmaterno); è quello che ha un atteggiamento di sostegno continuo al figlio. E’ sostenuto socialmente come fosse un genitore modello: attento, presente, premuroso. In realtà è troppo attento, di un’attenzione che si fa controllo; è troppo presente, tanto da non lasciare che il figlio si relazioni significativamente con altri; è troppo premuroso, al punto di evocare una relazione inclusiva, claustrofilica e simbiotica col figlio, una relazione che tende all’Uno. Una “presa” sul figlio che si alimenta di eccessiva prossimità, di confidenze segrete - “mio figlio mi dice tutto”, “mia figlia mi racconta ogni cosa” - e che depriva i figli del contatto con la propria vita intima, quella che dà a ciascuno il senso di esistere. Ognuno ha bisogno di un suo giardino segreto, di “una stanza tutta per sé”: il “dire tutto” è disumanizzante.
Il fine del genitore Pigmalione è di plasmare l’altro: un fine manipolatorio che ricorda da vicino la manipolazione dell’aguzzino della donna vittimizzata. Questo genitore esercita un controllo, e controllare è il contrario di educare; ha una vocazione al dogma, al pensiero Unico, aborrisce, infatti, la dialettica e il confronto. I figli inclusi mostrano una sorta di “passività” (come la donna vittimizzata di violenza) di fronte al genitore invasivo - invasivo per amore, s’intende - e si “lasciano fare” , manipolare, modellare da lui, a volte anche in età avanzata. Aguzzini e Pigmalioni irretiscono la vittima nel doppio regime di costrizione e premura.
La seconda ipotesi che voglio avanzare è che un figlio in ostaggio, così come una donna vittimizzata, manifestano, strutturalmente, un intreccio singolare e inedito di due costellazioni psichiche piuttosto note: quella di Stoccolma, in cui si ama il proprio rapitore, e quella di Stendhal, in cui l’animo sprofonda in uno stato di stupore abissale, quello per il quale, ad esempio, la donna appare come obnubilata, ipnotizzata dal suo offensore, al punto da “dimenticare” o minimizzare la molestia subita. Il figlio in ostaggio manifesta questa ipnosi nel non potersi svincolare dalla presa abusante del genitore invasivo e nell’accidia depressiva che lo prende quando non riesce ad allontanarsi dal genitore, neppure quando avrebbe l’età per doverlo fare. La donna vittima di violenza e il figlio in ostaggio, per sopravvivere fisicamente e psichicamente, finiscono per amare il proprio rapitore.
Un legame tossico con l’altro è quello che accomuna un figlio in ostaggio e una donna maltrattata e che si basa sul circuito maltrattamento/premura, coercizione/consenso inconscio e che si fonda su relazioni di dipendenza, plagio, abuso, false premure.
La posizione psichica dell’uomo violento è la stessa del genitore invasivo, simbiotico, possessivo. L’elenco che abbiamo stilato più sopra per il partner violento - controllore, possessivo, geloso, ricattatorio, colpevolizzante così da dominare la vittima che vuole isolare dal mondo - ci rendiamo conto, non senza un brivido, si potrebbe stilare identico anche per il genitore adesivo, simbiotico che tende a fare Uno con il figlio. Il genitore Pigmalione e il partner violento condividono la stessa tensione a farsi considerare dalle loro vittime come l’unico punto di riferimento significativo della loro vita.
La relazione stretta tra i due è testimoniata anche dal fatto che la legge che norma la violenza domestica (legge 154/2001) si riferisce a ogni maltrattamento familiare – sia tra partner che tra genitore e figlio. Il fatto che la segregazione psichica imposta dal genitore inclusivo e il fenomeno del partner violento rientrino, entrambi, nell’ambito normato da una stessa legge è una concordanza che ne esplicita, anche a livello sociale, la coincidenza strutturale inconscia.
Lo schema del partner violento ricalca quello del genitore inclusivo: l’attaccamento morboso gli consente di vivere a spese della vittima, di sentirsi vivo solo se essa gli è prossima: la può usare e consumare come una merce che lo tiene attivo e giovane; una droga, un elisir. Una volta divenuto adulto ed essendo stato svilito, un figlio o una figlia, potrebbe chiedere di consumare l’altro come il genitore ha consumato lui, oppure potrebbe continuare a farsi oggetto del godimento altrui.
La conclusione che avanzo, dunque, è che una famiglia inclusiva, retta dalla legge del genitore Pigmalione, o dal Plusmaterno, destina un figlio a relazioni con un partner con cui sia possibile instaurare legami altrettanto abissali e tossici di quelli che esistevano nell’abuso domestico. Le vite esposte alla violenza di queste figlie diventate adulte è come se rivelassero il tratto violento nascosto sotto la superficie eccessivamente amorosa della famiglia simbiotica. Il modo di amare di chi per primo ci ha amati è destinato a essere ripetuto, non solo perché è l’unica forma che conosciamo, ma soprattutto perché, in questo modo, le vittime possono, in un certo senso, assolvere implicitamente le figure amate nell’infanzia; e nella replica del “malamore”, possono dirsi che, se anche altri fanno cosí, è abbastanza normale che sia cosí. Non a caso, come abbiamo detto, uno dei meccanismi di difesa del soggetto sottomesso, infatti, è minimizzare il torto subíto.
In conclusione, pur se necessario, non basta affrontare il tema delle donne vittime di violenza domestica solo sul piano sociale e culturale, senza considerare le radici inconsce e strutturali che le portano a tollerare così a lungo l’aggressione. Occorre chiedersi: dove hanno imparato questo mix di violenza e amore, di coercizione e premura, di rapina e falso dono? La posizione dei figli in ostaggio ci offre una pista di pensiero. Non sarà certo l’unica, però possiamo dire che non riuscire a separarsi da un genitore invasivo può significare non riuscire a separarsi neppure da un partner distruttivo, se con lui pare possibile quel mondo che, pur infernale, di due sembra fare Uno.