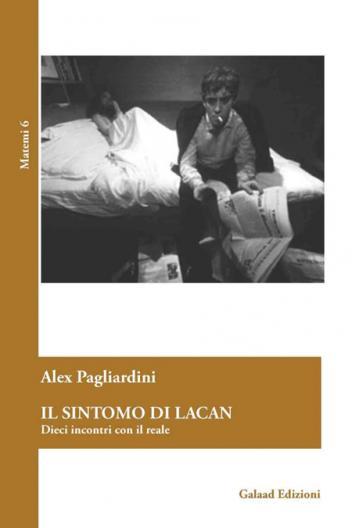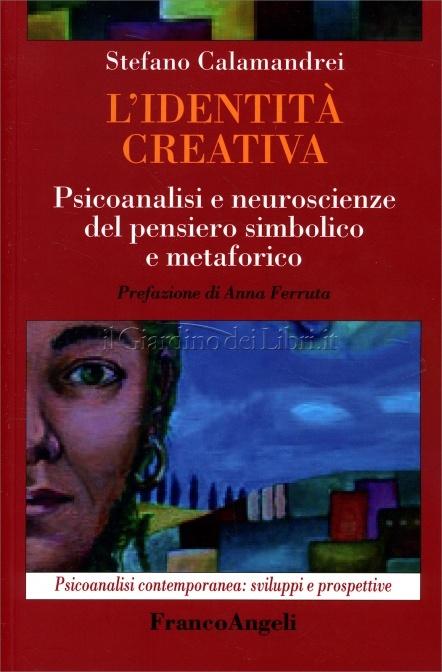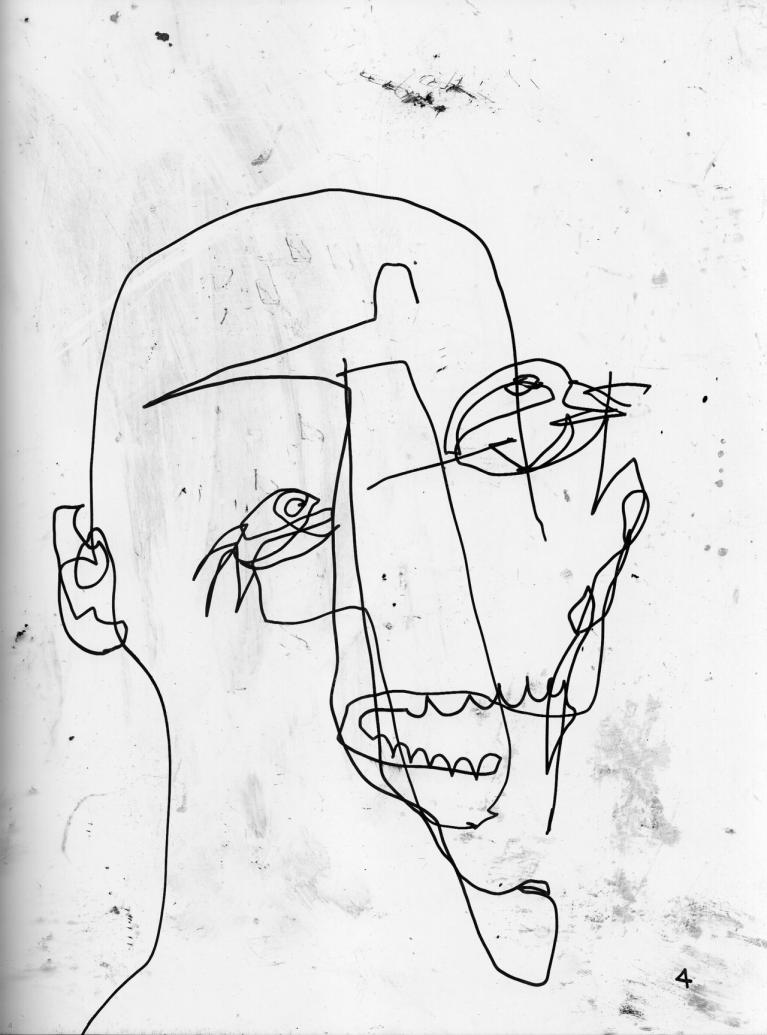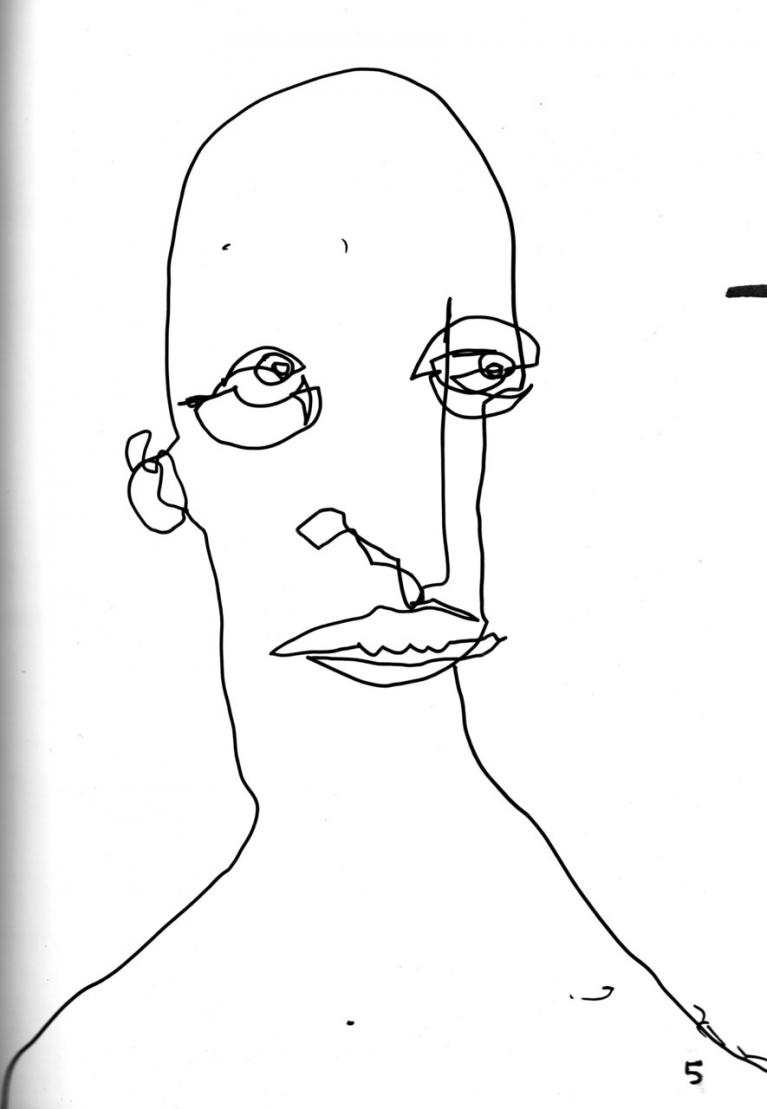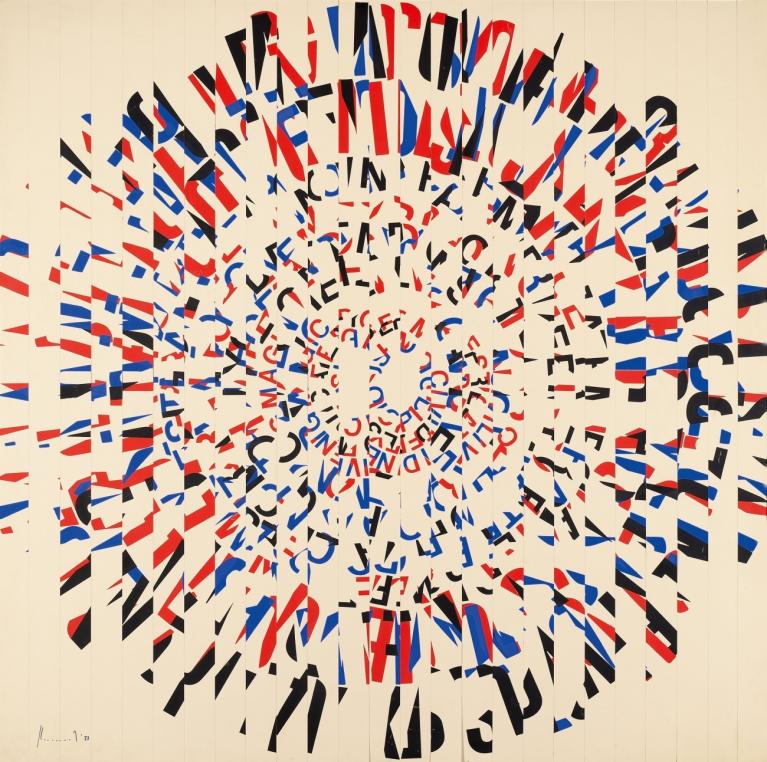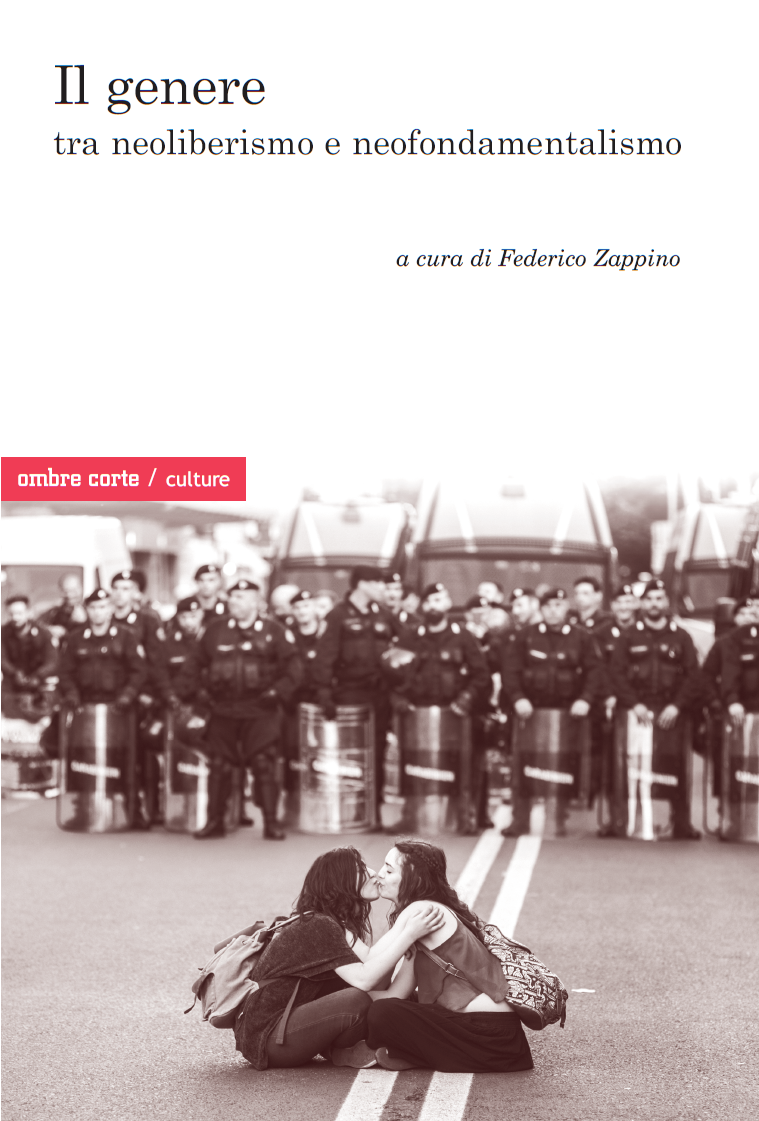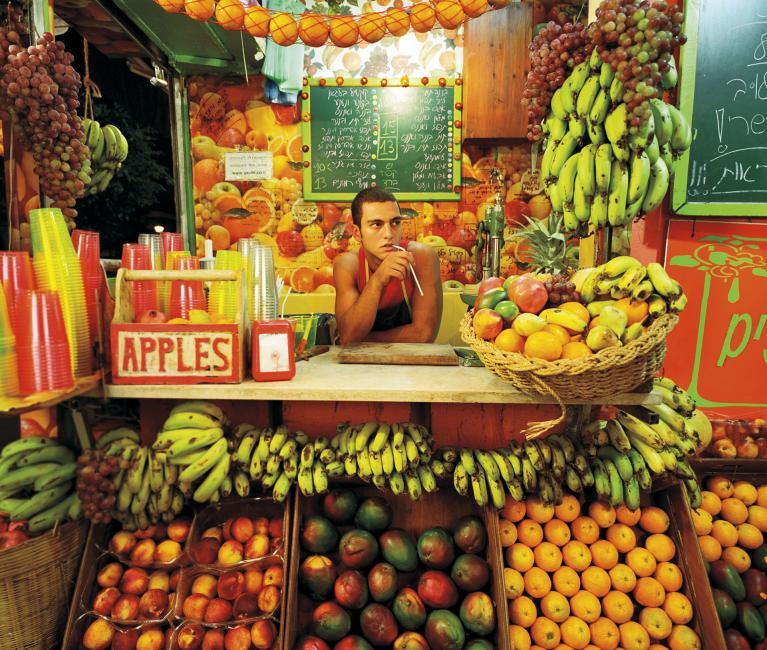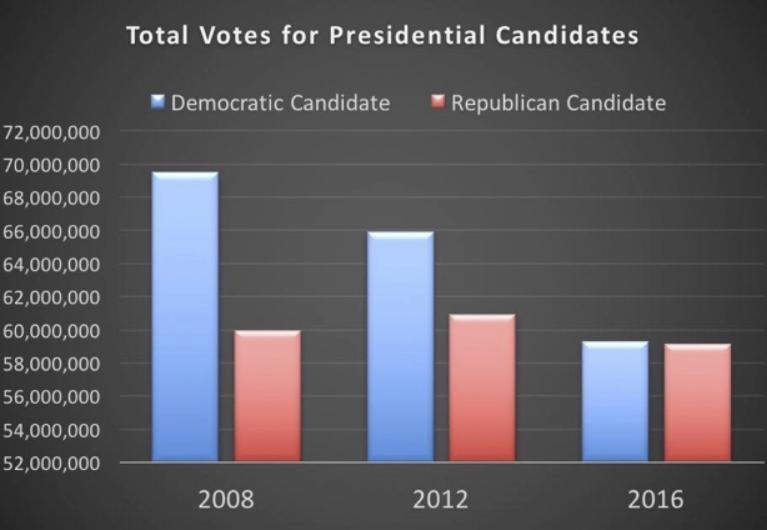Nel corso di tutto il suo insegnamento Lacan compie uno sforzo enorme, quello di intendere, sempre e comunque, ilcome e il doveè presente la causa negli effetti – in particolare in quegli effetti di cui la psicoanalisi si occupa e con i quali ha a che fare, e che prendono via via il nome di sintomo, di soggetto, di inconscio, di desiderio ecc.
Che cosa significa tutto ciò? Significa che Lacan ha cercato fin da subito, e progressivamente in modo più radicale e al contempo rovesciato, di intendere la “funzione”, il “peso” dell’incidenza del significante nel funzionamento del significante, della genesi della struttura nella struttura, della costituzione del soggetto nel soggetto costituito, del trauma nel traumatico, del taglio nel dispiegamento dell’inconscio ecc., dunque appunto la “funzione” e il “peso” della causa nell’effetto. Detto altrimenti Lacan sin dall’inizio del proprio insegnamento cerca di cogliere la funzione dell’accadere nell’accaduto, individuando in questo nodo un punto centrale della teoria e della pratica psicoanalitica.
Se si prende come riferimento il testo di apertura degli Scritti, La lettera rubata, si può cogliere come già questo Lacan, nella sua fase più propriamente strutturalista, non è interessato al funzionamento astratto della struttura ma alla sua incidenza, detto altrimenti non è interessato alla struttura ma allo strutturarsi della struttura o, se vogliamo, è interessato alla struttura in quanto modo di strutturarsi della struttura. Quello che nelle pagine di tale Scritto Lacan battezza caputmortum del significante altro non è che la presenza dell’accadere del significante all’interno del funzionamento significante. Il caput mortum del significante è il punto attorno al quale Lacan sviluppa gran parte del suo insegnamento, attribuendogli nomi e funzioni diverse, dal fallo al tratto unario, dal significante padrone al marchio. Proprio per questo è bene non dimenticare che in primis e al fondo, tale punto indica il comeè presente nel funzionamento della struttura il suo aver luogo, di come è presente il suo istituirsi nel suo essersi istituita, di come è presente l’accadere del significante nel suo essere all’opera, cioè nel suo essere accaduto, nel suo dispiegamento.
Tutto l’insegnamento di Lacan è dunque piegato a questa esigenza di maneggiare nel funzionamento significante, dunque nell’inconscio, l’atto che ripetutamente lo istituisce – di maneggiare ripetutamente questo nodo. Molte tortuosità del suo insegnamento trovano in questo nodo una delle ragioni di fondo. Il fatto che le tortuosità aumentino nel corso dell’insegnamento è l’indice ulteriore di una radicalizzazione di tale esigenza e allo stesso tempo di un rovesciamento interno a essa. Il rovesciamento consiste nel non intendere più, o non solo, il “piano” dell’accadere nell’accaduto ma nel maneggiarlo e intenderlo, se posso dire così, inpresadiretta, nel cogliere in sé il piano dell’accadere, fino a isolarlo nella sua separatezza, nel suo carattere assoluto.
Tra le operazioni più note di Lacan, che trova in questo nodo la sua ragione di fondo, c’è l’invenzione del “concetto” di lalingua, che è appunto il tentativo di cogliere in presa diretta il piano dell’incidenza del significante, il suo puro accadere, e non più e non solo estratto e dedotto dal funzionamento del significante. Allo stesso modo l’insistenza ottusa di Lacan sulla topologia rischia di essere uno sterile esercizio di elucubrazione se non vi si coglie il suo tentativo di frequentare l’accadere in sé e non l’accadere dedotto dall’accaduto, se non vi si coglie il tentativo di cogliere «la genesi in atto» (p. 68) dell’esperienza, del soggetto, dell’Altro, invece di dedurre la genesi, la causa, a cose fatte. In tal senso la topologia di Lacan se utilizzata come spiegazione del funzionamento dell’esperienza, dell’inconscio ecc., a cose fatte, è solo un esercizio retorico.

Questo nodo, a mio avviso decisivo in tutto l’insegnamento di Lacan, ha dunque due tempi. Nel primo, si tratta di maneggiare l’accadere nell’accaduto, cogliere l’accadere nell’accaduto. Nel secondo tempo si tratta di maneggiare l’accadere come tale, in sé.
La mia impressione è che questo nodo sia il punto più dimenticato dai lettori e interpreti di Lacan. Molti degli interpreti più significativi e raffinati non colgono affatto questo punto o lo relegano sullo sfondo. Le ragioni di questa sorta di oblio sono molte. Il testo di Federico Leoni, Jacques Lacan, l’economia dell’assoluto (Orthotes, 2016, pp. 158) ha il grande merito – merito enorme e impareggiabile – di assegnare, e riconsegnare, a questo nodo il peso che ha. Lo fa a modo proprio, concedendosi cioè sia il rigore sia il divagare, e lo fa non tanto muovendosi all’interno dell’insegnamento di Lacan quanto facendo muovere questo stesso insegnamento. Lo fa cioè non tanto attraverso un’indagine serrata dei passaggi dell’insegnamento di Lacan dove risuona prepotentemente il nodo in questione, ma andando a cogliere e lavorare una divisione dello stesso insegnamento di Lacan attorno ad alcuni grandi problemi. Questa divisione è ciò che fa intendere come ci sia un Lacan che si occupa dell’accadere attraverso il primato dell’accaduto, e un altro Lacan che si occupa dell’accadere attraverso il primato dell’accadere. La divisione è essa stessa un accadere, o detto altrimenti è l’indice di come Lacan sia sempre e da sempre alle prese con il problema dell’accadere in ciò e di ciò che accade.
La prima questione, e dunque la prima divisione di Lacan affrontata dal lavoro di Leoni, non poteva che essere quella del godimento. Niente evidenzia e niente dunque nasconde meglio del problema del godimento il nodo gordiano accadere-accaduto.
Lacan ha per molto tempo – senza mai smettere del tutto – cercato di intendere il godimento a partire dal simbolico e dall’immaginario, detto altrimenti a partire dalla legge, dal soggetto, dal desiderio, dal funzionamento dell’inconscio. Situato in tal modo, il godimento ha assunto varie declinazioni, incarnando la ripetizione, la spinta acefala e mortifera, l’eccesso dissipativo e traumatico che sempre abita e causa l’essere umano. Intendere il godimento sempre e solo a partire dal sapere, dal funzionamento del significante, non può che lasciarlo declinare e manifestarsi come rovina e/o eccesso dello stesso e nello stesso funzionamento significante.
Quando Lacan prova a intendere il godimento in sé – il SeminarioXIXè in tale direzione decisivo anche se non c’è un punto preciso di svolta ma una serie infinita di variazioni che portano Lacan in questa nuova prospettiva – si ritrova con tutt’altro problema tra le mani. Si trova infatti ad avere a che fare con un godimento che incarna il puro accadere, l’atto in atto, la pulsazione incessante, il taglio ripetuto: «vi sono dunque due godimenti, l’uno dal punto di vista della legge, come il suo residuo, il suo resto inassimilabile, che tuttavia la presuppone sempre e la rafforza costantemente; l’altro, che potremmo chiamare il godimento in sé, il godimento che accade al di fuori di ogni rapporto con la legge in quanto è istitutivo della legge stessa. In sé, questo godimento non è affatto un eterno ritorno (“cieco”, “mortifero”) dell’identico. È piuttosto l’evento incessante, ogni volta assolutamente unico, di una differenza pura. È il vivere inumano che continua a vivere al fondo del soggetto “umano”» (p. 25). Con Lacan possiamo dare un nome provvisorio a questi due godimenti: godimento fallico il primo, godimento Uno il secondo.
Uno è la cifra del puro accadere, dell’atto in atto, e dunque del godimento – Uno senza Altro lo chiama spesso Lacan. Due è la cifra degli accadimenti causati continuamente dall’accadere dell’Uno, è la cifra del movimento di soggettivazione, desiderante, causato incessantemente dall’accadere, cioè dall’Uno – Uno nell’Altro chiama spesso Lacan il come è presente l’Uno in questo movimento e in questo continuo spostamento che è poi la soggettività.
La pratica analitica deve maneggiare questo Uno nell’Altro per arrivare a toccare l’Uno senza Altro. Detto altrimenti la pratica analitica deve maneggiare il godimento in sé per come esso è presente nel movimento della soggettività, del quale è causa, per estrarre il godimento in sé e permettere all’analizzante di incontrarlo e a tratti di diventarlo (p. 151).
Da qui Leoni ricava una clinica del godimento, un’etica del godimento e un’economia del godimento da differenziare radicalmente da una clinica della mancanza-desiderio, da un’etica della mancanza-desiderio e da un’economia della mancanza-desiderio. Qui la sua tesi diventa radicale in quanto non viene proposta alcuna dialettica tra queste due dimensioni – e direi che tutto il testo certifica un certo disfarsi di qualsiasi forma di dialettica. La clinica-etica-economia della mancanza-desiderio non sarebbe dunque che un effetto del godimento Uno, dell’accadere dell’Uno e al contempo di un’operazione su di esso. Tale operazione origina nel dispositivo più profondo della metafisica di Aristotele, ossia la scomposizione dell’accadere della vita, del farsi della vita, in due dimensioni, la dimensione della potenza e la dimensione dell'atto. Da tale operazione consegue la suddivisione della vita tra un prima e un poi, tra un non-più e un non-ancora, la partizione della materia e della forma – in sostanza la separazione della vita da se stessa che fa della vita “mancanza di” e “ricerca verso”.
Ogni clinica-etica-economia della mancanza-desiderio di conseguenza non si occupa e non attiene al reale della vita, al reale della “sostanza delle cose”, perché non si avvede della fallacia epistemologica su cui si fonda, ossia quella di confondere l’accadere con l’accaduto, le cose fatte con ciò che le fa, il fatto con il farsi, il movimento con l’atto. Pertanto non si tratta di mettere in dialettica queste due cliniche, queste due etiche, queste due economie, ma di disgiungere il più possibile quella del godimento, quella dell’assoluto, da quella del desiderio, dello spostamento, e occuparsi esclusivamente della prima: «l’economia dell’assoluto non va detta dialetticamente, ma va “fatta” clinicamente, caso per caso, esperimento per esperimento» (p. 131)
Questa radicalità porta con sé altre due tesi radicali, vale a dire quella di un materialismo attualista e non di un materialismo sostanzialista e quella dell’autismo dell’Uno come pulsazione apertissima e non come chiusura mortifera.

Magritte, Les amants.
La prima tesi ha una portata clinica molto significativa. Con Lacan non dobbiamo cadere nel materialismo ingenuo e psicologico che suppone l’esistenza di una materia, di una sostanza, di un reale informe, della Cosa, su cui l’azione del linguaggio, della cultura, dell’Altro andrebbe a scavare una mancanza da cui l’istituzione del desiderio e della legge. La Cosa, la sostanza, la materia, è l’incidenza del taglio, taglio che l’accadere di ogni cosa che accade è, taglio che dunque non è taglio di niente ma taglio in sé, taglio in sé che è la vera materia, la vera sostanza, che non manca di niente ma che crea dal niente una materia ripartita e tagliata e dunque anche caratterizzata dalla mancanza: «ciò che apparirà mancante e ciò di cui esso apparirà mancante, sono figure tutte inscritte nell’atto di tagliare, che quanto a lui non è mancante di nulla, che quanto a lui è assoluto» (p. 43-44). La materia con la quale è alle prese la pratica analitica – e secondo Leoni ogni pratica che possa dirsi tale – non è dunque quella parte di materia che il linguaggio non è riuscito ad afferrare ma l’incidenza stessa del linguaggio, il suo accadere costantemente in atto.
L’Uno, come in parte visto, è la vera cifra di questo testo. L’Uno non è che l’evento dei molti, l’accadere di quel che accade, dunque non è che taglio di quel che si dispiega, non è che il farsi incessante della vita, di Una vita, sempre in atto nella vita vissuta e nelle sue molteplici esperienze, accadere della vita che è il tracciare, tagliare, incidere, marchiare, al fondo di ogni vita tracciata, tagliata, incisa, marchiata. La formula di Lacan “c’èdell’Uno” scrive proprio l’Uno come atto e non l’Uno come qualcosa che c’è – per questo Lacan non scrive “c’è l’Uno”. Autismo diventa il termine più adatto per nominare questo puro accadere, in quanto ne nomina efficacemente il “carattere” assoluto, cioè assolto dalla relazione, irrelato, separato. Ma usare un termine così pesante, così carico di significazione e così carico – se posso così dire – di dolore, usare il termine che più di ogni altro in psicoanalisi, e non solo, nomina la chiusura mortale e senza uscita, il buio della vita ripiegata su se stessa e per questo spenta e insopportabile, usarlo, appunto, per indicare il farsi della vita, va ben al di là della provocazione. Fare del termine autismo il nome dell’incessante farsi della vita, l’evento apertissimo del suo accadere, e non la chiusura della vita, la sua mostruosa contorsione, ha un valore paradigmatico, quello di smettere di intendere la vita a partire dal suo dispiegamento e frazionamento, dunque a partire dalla funzione dell’Altro, e iniziare a intenderla a partire dal suo semplice accadere.
In questa direzione si potrà forse un giorno intendere appieno cosa voglia dire il fatto che il nostro tempo è il tempo del desiderio, cioè del rinvio della vita come struttura della vita, ed è il tempo del simbolico, cioè della funzione di un Altro che separa sempre più la vita dalla vita, foss’anche in quella modalità nuovissima e vecchissima dell’imperativo a godere, che proprio in tal modo già di per sé stacca il godimento dall’atto e ne fa un qualcosa da cercare e avere. In questa direzione il testo di Leoni potrà forse un giorno farci intendere, e tenerne conto nella pratica clinica, cosa voglia dire che «non siamo fatti di atti, ma siamo sempre e soltanto un atto» (p. 48).